È martedì pomeriggio, sono da poco passate le 3 e davanti a me c’è un microfono.
Lo osservo con attenzione, si vede subito che ha almeno una decina d’anni. Istintivamente mi domando come sarà la resa una volta che aprirò bocca. Lo so, è un pensiero assurdo nella situazione in cui mi trovo. Mi concentro quindi su quello che sto per leggere. Non sono a mio agio, lo ammetto. E non è tanto per il fatto di non essere a casa mia o davanti al mio microfono.
Alzo lo sguardo e davanti a me, faccio un conto veloce, credo ci siano tra le 200 e le 300 persone.
Tutti mi stanno fissando in religioso silenzio e il peso di quegli sguardi lo sento tutto addosso. Probabilmente si stanno chiedendo cosa stia per leggere. Non lo sa nessuno cosa sto per leggere, tranne mia figlia di dieci anni. A lei ho semplicemente detto: «Vedrai che rideranno in più di un’occasione. Ti do un compito, conta quante volte».
A dirla tutta, fino a qualche ora fa nemmeno io sapevo se avrei letto qualcosa. Poi però ho mandato un messaggio alle mie sorelle e a mio fratello: «Se per voi va bene, vorrei leggere qualcosa».
Mi hanno risposto subito di sì, senza esitazione, ed è stata una boccata d’ossigeno.
Ora, però, ho una paura fottuta!
Butto uno sguardo furtivo allo smartphone per capire che ore sono ma non posso fare a meno di soffermarmi sull’icona di Spotify. Penso inevitabilmente alla puntata uscita oggi di Troubles, il mio ultimo podcast. È un episodio particolarmente forte, che inizia con il racconto di quanto accaduto durante due funerali celebrati a Belfast a fine anni ’80. Mentre rialzo lo sguardo non posso fare a meno di pensare a quanto sia beffardo il destino: con questo, oggi, fanno tre.
Scorgo la mia famiglia laggiù in fondo, in prima fila… E poco più avanti la bara di mio padre.
Non devi piangere, mi ripeto.
E non perché piangere sia qualcosa da nascondere o di cui vergognarsi ma perché quello che ho da leggere lo voglio leggere dannatamente bene, con la giusta espressività e dando il giusto peso alle parole. Solo in questo modo ciò che ho da dire su mio padre, penso, rimarrà impresso nei presenti più a lungo possibile. Proprio come in un podcast.
Quello del non piangere, per quanto assurdo, mi riporta alla mente un’altra incredibile coincidenza: nel primissimo episodio del mio primo podcast raccontavo proprio come io e mio fratello, ancora adolescenti, prendevamo in giro i miei genitori quando si commuovevano davanti alla TV con trasmissioni tipo Carramba che sorpresa!. Questo ricordo mi fa quasi sorridere, ma cerco di trattenermi.
Lo riconosco: non so se sia normale avere pensieri che rimandino continuamente ai miei podcast mentre sono qui al funerale di mio padre. Ma è un flusso di coscienza di cui ho scarso controllo. Anche questo foglio che ho in mano, ad esempio, l’ho scritto di notte e non posso fare a meno di pensare che la stessa identica cosa sia accaduta a Egidia Beretta Arrigoni per il funerale di suo figlio Vittorio, come lei stessa mi ha raccontato per Le Ali di Vik.
Poi capisco…
Capisco che in realtà mi è sempre piaciuto ascoltare e raccontare storie, di ogni tipo. Storie di vita vissuta, storie di persone più o meno normali che, nel bene e nel male, avevano qualcosa di importante da raccontare. Capisco che non si tratta di coincidenze, o peggio, di una mia personale ossessione per i podcast (sì, magari in parte). Ma che tutto dipende da quella inevitabile sensazione di dejà vu tipica dell’universalità delle storie che ho ascoltato e raccontato.
Nella primavera del 2019, ovvero poco prima di pubblicare il mio primo episodio (quello sul piangere, appunto), un giorno Rossella Pivanti mi disse: «La forza delle storie che raccontiamo o ascoltiamo non deriva tanto dalla storia in sé, ma dal fatto che queste storie, sebbene apparentemente insignificanti, sono storie di tutti, poiché universali».
Io non ho mai realmente compreso cosa mi spinga a fare podcast. Certamente una certa dose di egocentrismo, come negarlo?! Ma ci deve essere dell’altro. E credo che quell’altro lo stia riscoprendo proprio in questo momento, davanti a 200 o 300 persone che mi stanno fissando in silenzio e non sanno che probabilmente strapperò loro un sorriso. E credo sia il condividere una storia affinché tutti (io per primo) possano sentirsi – con le proprie fortune e disavventure – parte di una storia comune e quindi, forse, meno soli.
La mia paura iniziale la sento poco a poco svanire. Soprattutto ora che realizzo quanto sarei stato idiota se non avessi fatto quello che sto per fare davanti a persone che conosco bene. Quando negli ultimi quattro anni l’ho fatto con dei perfetti sconosciuti.
Apro quindi il foglio, prendo un respiro profondo, butto un occhio a mia figlia pronta a contare. Poi inizio a leggere scandendo bene le parole e con l’intonazione migliore di cui sono capace… Ecco un’altra storia, questa volta quella di mio papà.







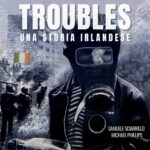
Leave a Reply